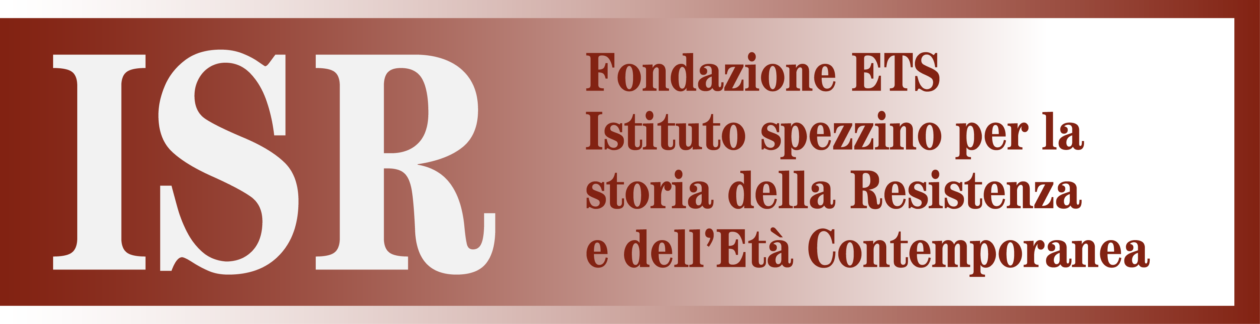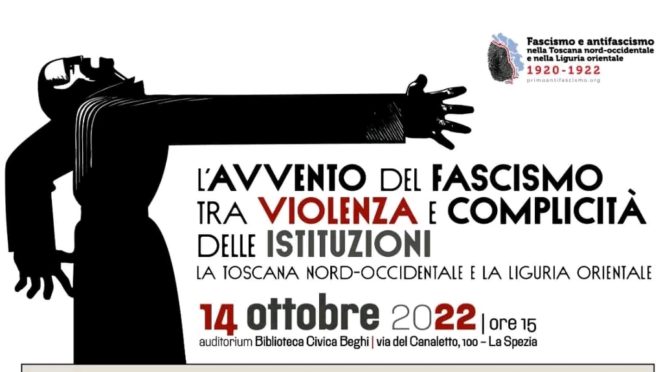Nell’anno del centenario dell’avvento del fascismo e nell’ambito della serie di incontri e convegni organizzati dalla rete Fascismo e antifascismo nella Toscana nord occidentale e nella Liguria orientale, 1920-1922, venerdì 14 ottobre, presso l’Auditorium della Biblioteca Beghi di La Spezia, si è svolto il convegno di studi dal titolo:
L’avvento del fascismo tra violenza e complicità delle istituzioni: la Toscana nord-occidentale e la Liguria orientale.
Questo il video integrale del convegno, pubblicato sul canale YouTube della Biblioteca Franco Serantini; di seguito i collegamenti diretti agli interventi.
Origini del fascismo e avvento al potere, 1919-1922
Marco Palla
(Università di Firenze)
min. 6:32
Cent’anni di fascismo “buono”. Potenzialità e insidie del debunking storico
Carlo Greppi
(storico, scrittore)
min. 46:58
Per un Atlante delle violenze politiche del primo dopoguerra italiano. Pratiche e riti della violenza politica
Giulio Taccetti
(borsista Istituto nazionale F. Parri)
min. 1:12:30
Per un Atlante delle violenze politiche del primo dopoguerra italiano. Uno sguardo dall’Archivio centrale dello Stato
Lorenzo Pera
(borsista Istituto nazionale F. Parri)
min. 1:33:08
Fascismo e antifascismo a Carrara e dintorni
Massimo Michelucci
(ISRA – Istituto Storico della Resistenza Apuana)
min. 1:54:29
Cronologia 1921-1922: uno strumento didattico e di conoscenza storica. Un obiettivo sul territorio spezzino e dintorni
Maria Cristina Mirabello
(ISR – Istituto spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea)
min. 2:27:59
Le origini culturali e politiche del fascismo pisano nel contesto dello sviluppo dei movimenti interventisti della Toscana Nord Occidentale
Franco Bertolucci
(Biblioteca Franco Serantini)
min. 2:40:47
Fascismo e antifascismo alla Spezia: l’industria militare, la Marina, la classe operaia
Giorgio Pagano
(Comitato provinciale Unitario della Resistenza – La Spezia)
min. 3:08:41